Indice
- 1 Premessa
- 2 Giuseppe Ungaretti, poesia di spietata sincerità
- 3 Una liturgia consolatoria
- 4 Il ciottolo di Zbigniew Herbert
- 5 Inerte e pieno di dignità
- 6 Wisłava Szymborska, di fronte al vuoto
- 7 Il senso del partecipare, la sfida della poesia
- 8 Charles Simic, fuori dal sasso è tutto mistero
- 9 La poesia e il paradosso, sua spezia segreta
- 10 Nei territori di confine
Il quadro che ho scelto per questo testo è di Stefano Paci ed è stato esposto in una sua personale a Limassol (Cipro) dal titolo No relations nel 2015.
Premessa
“A ben guardare – scrive Carlo Rovelli – anche le ‘cose’ che più sembrano ‘cose’non sono in fondo che lunghi eventi. Il sasso più solido, alla luce di quello che abbiamo imparato dalla chimica, dalla fisica, dalla mineralogia, dalla geologia, dalla psicologia, è in realtà un complesso vibrare di campi quantistici, un interagire momentaneo di forze, un processo che per un breve istante riesce a mantenersi in equilibrio simile a sé stesso, prima di disgregarsi di nuovo in polvere, un capitolo effimero nella storia delle interazioni fra gli elementi del pianeta” (L’ordine del tempo, Adelphi 2017).
Dunque, da un lato abbiamo le conoscenze, sempre più circostanziate, delle scienze, e dall’altro le intuizioni e le emozioni e le fantasie degli esploratori del linguaggio, quelli che hanno provato e provano a ridisegnare le storie della nostra percezione del mondo.
Qualcuno ha messo insieme i due sguardi, quello scientifico e quello poetico: Lucrezio, ovviamente, ai vertici, e immagino lo stupore di Poggio Bracciolini quando un monaco tedesco nel 1417 apre davanti ai suoi occhi un polveroso codice dimenticato da un millennio e qualche secolo.
Il monaco non lo sapeva, quello era il De rerum natura, pericolosissimo leggerlo e un suicidio divulgarlo… molto più tranquillo il viaggio della Piccola cosmogonia portatile di Raymond Queneau (Einaudi, 2003). Qui proviamo a interrogare altri esempi.
La poesia che descrive un sasso, che si chiede che cosa sia un sasso, o una pietra, o immagina qualcosa nel sasso. Un breve percorso, prelevato dalle opere di Giuseppe Ungaretti, Zbigniew Herbert, Wisłava Szymborska e Charles Simic.
Giuseppe Ungaretti, poesia di spietata sincerità
Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura (da Il porto sepolto, 1916)
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
la morte
si sconta
vivendo
 Se con la mano anche noi puliamo un po’ la polvere del tempo, ritorna alla luce questa pietra ungarettiana: fredda, dura, prosciugata, refrattaria, totalmente disanimata.
Se con la mano anche noi puliamo un po’ la polvere del tempo, ritorna alla luce questa pietra ungarettiana: fredda, dura, prosciugata, refrattaria, totalmente disanimata.
L’immagine della morte, quella che – dice Ungaretti – si sconta vivendo. Quella pietra senza vita ci sta accanto come la parte oscura della vita.
Ungaretti si trova nel Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916, quando scrive questi versi. C’è la guerra mondiale che sta frantumando tutto quello che la civiltà occidentale pensava di rappresentare. Ungaretti usa queste monadi verbali (come le ha definite Pier Vincenzo Mengaldo) per dilatare la forza del singolo vocabolo, usa un lessico antiletterario, e affida a questa scansione molecolare il dramma della sua condizione.
La trincea e Leopardi gli hanno insegnato le parole di una spietata sincerità: queste saranno in effetti le sue confessioni, qualche anno dopo: la trincea e Leopardi. Il pericolo imminente della propria morte, vicinissimo, come la pietra che descrive, e il pensiero sulla condizione umana, l’arido vero leopardiano, senza illusioni filosofiche.
Una liturgia consolatoria
Quel precipitare di aggettivi fino al punto più basso (e più alto, come vertice della tensione), cioè quel DISANIMATA che è un recupero dantesco, è come un toccare, tastare, qualcosa che ha concluso il suo ciclo e può essere usata soltanto come comparazione: “quando disanimato il corpo giace” scrive Dante nel Purgatorio (XV, 135). Eppure, in questa poesia di Ungaretti, insieme a questo annullarsi nelle cose c’è una specie di liturgia consolatoria, una preghiera nascosta, che è un modo di consolarsi affermando la propria vicinanza terrestre a quella cosa fredda, dura, prosciugata (senza l’elemento vitale dell’acqua), refrattaria (che rifiuta ogni tipo di relazioni) e disanimata, addirittura senza anima, non solo senz’acqua.
Questa sua aggettivazione tattile assomiglia a uno scongiuro. Non voglio diventare come questa pietra, dice Ungaretti, anche se i miei sentimenti già si sono pietrificati. Ma nello stesso tempo la pietra di paragone fa parte della natura, come tutti quegli uomini, amici e nemici, che si stanno uccidendo.
Fratelli, li apostrofa Ungaretti in un’altra poesia. Amici e nemici, comunque fratelli. Mentre la natura – e qui è Leopardi che parla attraverso Ungaretti – è fraterna ma inquietante, materna ma indifferente.
La pietra non è analizzata nei suoi componenti o nei suoi colori, nell’assenza di colori, nelle venature: sono qualità inutili. Non si vedono, come il pianto del poeta, che ormai non ha più lacrime. E la morte, invisibile e vicina è sempre presente. Qui la pietra rappresenta concretamente temporalità diverse, umane e geologiche: viene da preistorie lontanissime e sembra aspettarci fuori dalle nostre storie.
Il ciottolo di Zbigniew Herbert
Zbigniew Herbert, Il ciottolo (da Studio dell’oggetto, 1961)
Il ciottolo è una creatura
perfetta
uguale a sé stesso
attento ai propri confini
esattamente ripieno
di senso pietroso
con un odore che non ricorda nulla
non spaventa nulla non suscita pensieri
il suo ardore e la sua freddezza
sono giusti e pieni di dignità
provo un grave rimorso
quando lo tengo nel palmo
e un falso calore
ne pervade il nobile corpo
I ciottoli non si lasciano addomesticare
fino alla fine ci guarderanno
con un occhio chiaro e molto calmo
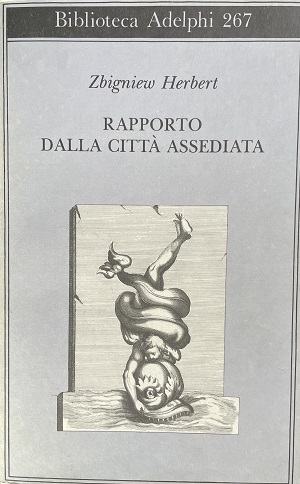 Il ciottolo di Zbigniew Herbert è invece una creatura perfetta. “ Esattamente ripieno / di senso pietroso ”. Pietra, solo pietra. Ma in quel ‘senso pietroso’ avvertiamo un’ironia sotterranea. Anche questo ciottolo è inevitabilmente freddo e senza odori, ma viene magicamente personificato dallo sguardo di Herbert quando dice: “ i ciottoli non si lasciano addomesticare / fino alla fine ci guarderanno / con un occhio chiaro e molto calmo ”. Il duro e la durata attingono alla stessa etimologia e contrastano con la precarietà e illusorietà delle passioni umane. Non si può dire molto di un ciottolo, ma guardandolo viene da sorridere amaramente.
Il ciottolo di Zbigniew Herbert è invece una creatura perfetta. “ Esattamente ripieno / di senso pietroso ”. Pietra, solo pietra. Ma in quel ‘senso pietroso’ avvertiamo un’ironia sotterranea. Anche questo ciottolo è inevitabilmente freddo e senza odori, ma viene magicamente personificato dallo sguardo di Herbert quando dice: “ i ciottoli non si lasciano addomesticare / fino alla fine ci guarderanno / con un occhio chiaro e molto calmo ”. Il duro e la durata attingono alla stessa etimologia e contrastano con la precarietà e illusorietà delle passioni umane. Non si può dire molto di un ciottolo, ma guardandolo viene da sorridere amaramente.
A questo punto, siamo sicuri che il ciottolo sia soltanto un sasso? Herbert, dopo la caduta del muro di Berlino, si era rammaricato per la scomparsa della censura nella Polonia comunista, perché lui aveva elaborato uno stile per aggirarla, uno stile allegorico. Se rileggiamo sotto questa prospettiva gli ultimi tre versi, e anche quelli precedenti, riusciamo a intuire che nel ciottolo si era mimetizzato chi non può parlare, chi è costretto a non ricordare nulla, a non farsi venire dei pensieri autonomi, sebbene il suo ardore e la sua freddezza siano pieni di dignità, dentro quel ‘nobile corpo’, e infine “i ciottoli non si lasciano addomesticare / fino alla fine ci guarderanno / con un occhio chiaro e molto calmo”.
Inerte e pieno di dignità
Forse adesso certe aggettivazioni risultano più comprensibili, e il mimetismo, questo fingersi inerte come un ciottolo e nello stesso tempo “pieno di dignità”, rivela il doppiofondo o il doppio senso: Herbert è stato un oppositore del regime comunista polacco. Francesco Cataluccio, che lo ha seguito in Polonia e nei suoi soggiorni italiani, ha scritto che la poesia di Herbert non è mai stata “impegnata”, anche se le sue idee e le sue metafore hanno spesso mandato in bestia la censura polacca.
Un esempio, quando Herbert diceva di avere una predilezione per il trattato di Stalin sulla linguistica, una predilezione ovviamente sarcastica: “nei momenti in cui Pickwick delude, mi metto a leggere Stalin e mi torna il buonumore”…
Dunque il senso petroso depositato nel sasso è quella dignità che non si lascia riscaldare in modo effimero, e se il regime dura, persiste, io duro di più, sembra dire il poeta, come un sasso, e resisto ribadendo me stesso, chiuso nei miei limiti e confini, ma proiettato verso il futuro.
In questo caso, la pietra diventa allegoria, viene usata per questo, è un’immagine che porta con sé un contenuto nascosto. Perché un sasso? Si stabilisce in effetti una relazione tra il poeta e il sasso, e il sasso viene scelto perché rappresenta quanto di più inerte e sostanzialmente muto possa esistere. Muto in questo caso ha un significato più profondo: non parla perché non può farlo, ma potrebbe o dovrebbe farlo, e noi dovremmo imparare “dal suo occhio chiaro e molto calmo” che guarda verso di noi, e mette a nudo la nostra ipocrisia di parlanti.
Continuando la ‘polonaise’ incontriamo la Szymborska che conversa con una pietra.
Wisłava Szymborska, di fronte al vuoto
Wisłava Szymborska, Conversazione con una pietra (da Sale, 1962)
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
Voglio venirti dentro,
dare un’occhiata,
respirarti come l’aria.
Vattene –dice la pietra-
Sono ermeticamente chiusa.
Anche fatte a pezzi
saremmo chiuse ermeticamente.
Anche ridotte in polvere
non faremo entrare nessuno.
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
Vengo per pura curiosità.
La vita è la sua unica occasione.
Vorrei girare per il tuo palazzo,
e visitare poi anche la foglia e la goccia d’acqua.
Ho poco tempo per farlo.
La mia mortalità dovrebbe commuoverti.
Sono di pietra –dice la pietra-
e devo restare seria per forza.
Vattene via.
Non ho i muscoli del riso.
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
Dicono che in te ci sono grandi sale vuote,
non viste, inutilmente belle,
sorde, senza l’eco di alcun passo.
Ammetti che tu stessa ne sai poco.
Sale grandi e vuote –dice la pietra-
ma in esse non c’è spazio.
Belle, può darsi, ma al di là del gusto
dei tuoi poveri sensi.
Puoi conoscermi, però mai fino in fondo.
Con tutta la mia superficie mi rivolgo a te,
ma tutto il mio interno è girato altrove.
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
Non cerco in te un rifugio per l’eternità.
Non sono infelice.
Non sono senza casa.
Il mio mondo è degno di ritorno.
Entrerò e uscirò a mani vuote.
E come prova d’esserci stata davvero
porterò solo parole,
a cui nessuno presterà fede.
Non entrerai –dice la pietra-
Ti manca il senso del partecipare.
Non c’è senso che possa sostituirti quello del partecipare.
Anche un vista affilata fino all’onniveggenza
non ti servirà a nulla se non hai il senso del partecipare.
Non entrerai, non hai che una sensazione di quel senso,
appena un germe, solo una parvenza.
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
Non posso attendere duemila secoli
per entrare sotto il tuo tetto.
Se non mi credi –dice la pietra-
rivolgiti alla foglia, dirà la stessa cosa.
Chiedi a una goccia d’acqua, e ti dirà
quel che ha detto la foglia.
Chiedi infine a un capello della tua testa.
Scoppio dal ridere, d’una immensa risata
che non so ridere.
Busso alla porta della pietra.
-Sono io, fammi entrare.
-Non ho porta- dice la pietra.
L a poesia è dei primi anni sessanta, circa. Sulla natura delle cose cominciavano a diffondersi aspetti inquietanti e imprevedibili. La fisica quantistica non era più un discorso tra quattro esperti e le bombe atomiche, la minaccia nucleare, i primi voli spaziali, si trovavano su tutti i giornali.
a poesia è dei primi anni sessanta, circa. Sulla natura delle cose cominciavano a diffondersi aspetti inquietanti e imprevedibili. La fisica quantistica non era più un discorso tra quattro esperti e le bombe atomiche, la minaccia nucleare, i primi voli spaziali, si trovavano su tutti i giornali.
Qui le allusioni sono abbastanza chiare, benché la poetessa polacca non avesse a disposizione la letteratura scientifica di divulgazione che abbiamo noi oggi. Eppure quando parla di stanze vuote dentro la pietra, come non pensare all’agglomerato di atomi che la compongono? Tra il nucleo di un atomo e un elettrone che gli gira attorno c’è la distanza che possiamo immaginare tra un pallone di calcio al centro del campo e una piccola biglia che corre sugli spalti più lontani. Il resto è vuoto.
Il senso del partecipare, la sfida della poesia
La scienza, tanti secoli dopo Lucrezio, e con un’accelerazione incredibile in questi ultimi decenni, ci sta descrivendo un mondo totalmente inaspettato, incredibile, spesso per noi controintuitivo. “ Con tutta la mia superficie mi rivolgo a te / ma tutto il mio interno è girato altrove ”. Credo che non si possa dire meglio, con una semplicità e un’arguzia formidabili. Non è una pietra di paragone, una cosa arida, refrattaria, da portare di peso in poesia. Il discorso della Szymborska sembra ambivalente: da un lato spiega che anche una pietra è composta principalmente di vuoto, dall’altro la natura in generale irride la ricerca umana.
Qui la poesia e la scienza bussano inutilmente. “ Non ho porta – dice la pietra ”. Anche quando la pietra diventa un granello di sabbia, nella poesia che dà il titolo a una sua raccolta poetica, ogni paragone “ è solo nostro ”, appartiene alla nostra cultura incompleta. La pietra o il granello di sabbia racchiudono infatti una “notizia non umana”. Ma anche con questa affermazione, si resta nel dubbio: che cosa è propriamente umano e che cosa non lo è? “Sono una domanda in risposta a un’altra domanda” dice la poetessa polacca. Forse il punto più illuminante della conversazione si trova nei versi “Anche una vista affilata fino all’onniveggenza / non ti servirà a nulla se non hai il senso del partecipare”. Ecco dunque la percezione di fare parte della stessa materia di cui fa parte anche la pietra. E questa percezione stranamente non è diffusa e condivisa. “Non hai il senso del partecipare”. In effetti l’opera poetica della Szymborska cerca di ricostruire un senso del partecipare, è una interrogazione senza fine, che si aggiorna, libro dopo libro, poesia dopo poesia. In questo penso che consista il suo insegnamento. Cioè – sebbene sarà difficile arrivare fino al fondo delle cose – dobbiamo aggiornare costantemente le conoscenze, questo è il nostro compito e forse anche il nostro destino, qualunque sia il finale che ognuno può diversamente prospettare. Tuttavia questo testo ci colloca di fronte a un limite, perché Quello di cui la natura non ha bisogno (titolo di un libro del linguista americano Derek Bickerton) è proprio il linguaggio. Per questo ogni poesia è una sfida ai limiti della parola.
Charles Simic, fuori dal sasso è tutto mistero
Conclusione provvisoria e inconcludente. Charles Simic, Sasso (da Hotel insonnia, 2002)
Va dentro un sasso,
io lo farei.
Se qualcuno diventa una colomba
o come una tigre digrigna i denti, faccia pure.
Io sono felice di essere un sasso.
Fuori dal sasso è un enigma:
nessuno sa come rispondere.
Ma lì dentro, deve essere fresco e tranquillo
anche se una mucca ci cammina sopra con tutto il suo peso,
anche se un bambino lo lancia dentro un fiume:
il sasso affonda lento, imperturbato
sul fondo del fiume
dove i pesci vengono a bussare
e ascoltano.
Ho visto sprizzare scintille
quando due sassi vengono strofinati,
forse lì dentro non è così buio, dopo tutto;
forse c’è una luna che splende
da qualche parte, magari dietro una collina –
abbastanza luce da decifrare
quelle strane scritture, le mappe stellari
sui muri interni.
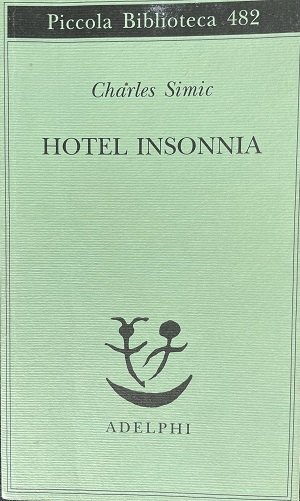
“Va dentro un sasso / io lo farei”. Perché? Perché fuori dal sasso è tutto un mistero, anzi un enigma, mentre lì dentro “deve essere fresco e tranquillo”. Ci sono pesci che bussano alla superficie del sasso e sembrano origliare.
Forse, dice Simic, “c’è una luna che splende / chissà dove” ma sempre dentro il sasso, e sui muri interni ci saranno strane scritture, mappe stellari. Un’intuizione felice quella del sasso come una caverna, con iscrizioni rupestri. Proprio perché è controintuitivo, come dice Richard Dawkins: “che la materia solida, anche il durissimo diamante, sia costituita quasi interamente di spazio vuoto”. Ma così è. Il mondo come ci appare nella vita quotidiana, colori odori voci, ombre piante animali, la nostra stessa esistenza con le sue scelte quotidiane… e poi come si rapportano queste cose percepite dai nostri sensi molto approssimativi con gli atomi, le molecole, gli elettroni, i quark, e il loro vorticante dinamismo, che possiamo raggiungere solo con strumenti complicatissimi e altrettanto complicate formule matematiche?
La poesia e il paradosso, sua spezia segreta
La poesia di Simic riesce a farci pensare a queste cose utilizzando una visionarietà che si nutre anche di incontri fantastici, accostamenti di realtà che appartengono a contesti diversi. “È il sapore paradossale della poesia che la rende sapida”, cioè saporita, arguta. “Il paradosso è la sua spezia segreta” aggiunge Simic.
Non voglio affermare che Simic sia un poeta che si confronta con quelle descrizioni scientifiche della realtà che hanno sconvolto e continuano a sconvolgere la nostra percezione del mondo. È un poeta senza certezze che affida al linguaggio e ai suoi cortocircuiti improvvisi gli aggiustamenti della propria comprensione delle cose: cerco un equivalente dell’abisso che precede il linguaggio, dice. Questo modo di sentire è aperto, incerto e drammatico, relativistico e lucidamente ironico.
Il sasso è in effetti come una caverna preistorica. È il risultato di compressioni millenarie, racchiude una storia, trascritta in graffiti misteriosi, e noi facciamo come i pesci, proviamo a bussare, guardare e ascoltare. Ma il poeta sa già che chi ha fatto pensieri profondi – come ha scritto Simic nei suoi taccuini – si è ritrovato solo e senza parole.
Nei territori di confine
Incontri ravvicinati del terzo tipo è una iperbole che si potrebbe usare per questi tentativi poetici di approccio alla natura inanimata, fatti con i mezzi che di solito la poesia usa, percezioni, sentimenti, ragionamenti, visioni, immaginazione, e soprattutto una fusione di questi elementi. Iperbole, perché non si tratta di cose inaccessibili, anzi sono intrinsecamente terrestri, e siamo noi che stiamo diventando stranieri nel mondo che ci ha svezzato; in effetti ci stiamo gradatamente modificando rispetto ad una realtà che mostra aspetti impensabili e che richiedono una consapevolezza che va oltre i nostri sensi.
Abbiamo visto che delle semplici rocce, dal nostro punto di vista inanimate, in realtà, al loro interno, sono estremamente dinamiche, e la poesia in qualche modo lo ha percepito. “Se guardiamo un sasso, sta fermo. Ma se potessimo osservare i suoi atomi, li vedremmo in perenne vibrazione … un oggetto è un processo monotono, un processo che si ripete uguale a sé stesso per un po’ ” (proseguiva Carlo Rovelli). Ma come si fa ad avere consapevolezza di realtà che stanno oltre la portata delle nostre percezioni? Questo è il succo del discorso. La nostra esperienza ha bisogno di strumenti per conoscerle. Protesi, dispositivi estremamente sensibili. Non è più una conoscenza diretta. Siamo entrati in un mondo strano, dove la saggezza e la visionarietà della poesia (e non solo della poesia) dovrebbero confrontarsi continuamente con questo proliferare di nuovi dati, con descrizioni che esistono contemporaneamente alla realtà che tutti sperimentiamo e che raggiungono i nostri sensi attraverso strumenti che la ricostruiscono, spesso statisticamente. Forse anche il nostro sistema nervoso agisce in modo simile.
La poesia, specialmente la poesia lirica, è costantemente alla ricerca della realtà profonda, lo fa in tanti modi, interpretando con il linguaggio i segnali più disparati. La sua lingua è sintomatica. Le sue radici succhiano da ogni disciplina. Ma quanto le conviene restare dentro il suo piccolo grande mondo mentre le scienze le stanno portando via i territori dell’immaginazione? Ed è in grado di farlo? Non lo so. Anche perché sullo sfondo, per tutti, resta la paura del buio. “Con tutta la mia superficie mi rivolgo a te / ma tutto il mio interno è girato altrove” rispondeva la pietra della Szymborska.
Sembra una variazione del dialogo della natura e di un islandese, dove la natura avverte il rappresentante dell’umanità che una eventuale scomparsa del genere umano per lei sarebbe del tutto indifferente. Un duro confronto. Insomma, le poesie ci portano fino a questo punto, su territori di confine. E lì, nello zaino, bisogna mettere tante cose utili, ma che siano davvero utili.
Bibliografia
Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo. Tutte le poesie. Mondadori 2016
Andrea Cortellessa, Le notti chiare erano tutte un’alba, Mondadori 1998
Zbigniew Herbert, Rapporto dalla città assediata. Adelphi 1993
Francesco Cataluccio, Vado a vedere se di là è meglio. Sellerio 2010
Wislawa Szymborska, Vista con granello di sabbia. Adelphi 2003
Charles Simic, Hotel insonnia. Adelphi 2002
Carlo Rovelli, L’ordine del tempo. Adelphi 2017

